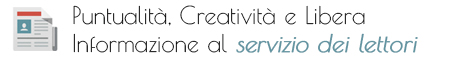Disciplina antica la Retorica, arte del dire, arte del linguaggio.
Antica di almeno 2500 anni durante i quali è divenuta oggetto di tutta una complessa serie di dottrine, tecniche e precetti che richiedono alcune precisazioni per quanto riguarda definizione e campi di appartenenza.
Distinguiamo, a tal fine, una Retorica Ornata e una Retorica Figurata.
La Retorica Ornata è quella per la quale sono stati espressi giudizi sempre più negativi a partire soprattutto dall’età romantica e successivamente da Benedetto Croce che la considerava addirittura offensiva nei confronti della Poesia.
Fatto, questo, che ne ha determinato tenacemente il declino bollandola di insincerità, di sinonimo di vaniloquio finalizzato alla persuasione, all’artificio, alla superficialità esteriore, a scapito della sostanza e della verità.
Essa è lontana dalla poesia poiché si presenta come arte del discorso prosastico.
La Retorica Figurata è invece quella che ha consentito, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, una rivalutazione di questa antica disciplina.
Tale rivalutazione ha nel concetto di “Figura” il suo più importante riferimento che possiamo accostare a quello più antico di “Tropo”.
I due termini, sebbene non siano da considerare uguali, esprimono comunque quello slittamento in senso metaforico del significato di una parola, che trasforma il linguaggio da denotativo, cioè descrittivo-referenziale tipico del linguaggio comune, a connotativo, tipico invece del linguaggio poetico, consentendo alla stessa parola di acquisire più significati e più sensi in modo da superare quella inopia linguistica, cioè quella insufficienza che il linguaggio denotativo possiede.
La differenza tra tropo e figura, a volere essere precisi, risiede nel fatto che la parola oggetto dello slittamento metaforico è insostituibile nel caso del tropo, sostituibile con altre parole nel caso della figura.
Quando diciamo, per fare degli esempi che riguardano il concetto di tropo, “il piede del tavolo, il collo della bottiglia, la mano del destino, un occhio di riguardo”, ecc. attribuiamo al tavolo, alla bottiglia, al destino, parole come piede, collo, mano che comunemente, nel linguaggio descrittivo-referenziale, denotano parti del corpo umano e che ora abbiamo metaforicamente trasferito a cose, siano esse astratte o concrete, senza che sia possibile sostituirle con altre parole.
Ed è proprio questa insostituibilità che conduce all’abuso di quelle espressioni che pertanto da figurate divengono abituali a tal punto da perdere quello spazio che lo slittamento metaforico deve creare, nel significato e nel senso, tra ciò che si dice e ciò che si vuole dire.
Ne deriva una catacresi che accentua l’inopia del linguaggio denotativo.
Nel caso invece della “figura”, se diciamo: “esile come un bastoncino da passeggio”, l’esilità che vogliamo esprimere può avvalersi, potenzialmente, di altre parole diverse da “bastoncino” come fil di fumo, spaghetto, finanche dell’espressione ”come un sibilo”.
La sostituibilità della parola, nel caso delle figure retoriche, sembrerebbe in contrasto con quanto abbiamo affermato finora, cioè che nel testo poetico, a differenza degli altri tipi di testo, la parola non è sostituibile con altre parole senza compromettere gravemente la struttura metrico-fonico-ritmica e di contenuto del testo stesso.
Si tratta di contraddizione apparente in quanto riferita a possibilità teorica e potenziale che ci è servita a distinguere i due concetti di tropo e di figura sulla base della possibilità o meno di scelta della parola.
La Retorica in definitiva si avvale di artifici che il Poeta crea e utilizza per piegare la parola alle proprie esigenze metriche, foniche, timbriche che a loro volta sono intimamente connesse ad esigenze espressive e di contenuto che possono spingersi fino alla rottura del patto linguistico stabilitosi tra i parlanti o alla creazione di cosiddetti idioletti, cioè linguaggi affatto tipici di quel poeta o scrittore del quale pertanto consentono facilmente l’identificazione.
Poiché la parola, cioè il segno dal punto di vista linguistico, sappiamo essere costituita da una componente fisica (suono, forma, posizione) denominata “Significante” e da una componente concettuale denominata “Significato”, la prima grande classificazione, nell’ambito delle figure retoriche, potrebbe essere costituita da: 1) Figure del Significante; 2) Figure del Significato.
Ad alcuni sembrerà subito troppo rigida e semplicistica tale suddivisione ed in effetti non avrebbero tutti i torti dal momento che per alcune figure retoriche si hanno difficoltà notevoli a collocarle nell’una o nell’altra delle due classi.
Non dimentichiamoci inoltre che nel linguaggio connotativo, soprattutto del testo poetico, come abbiamo già ripetutamente asserito, tutto diventa significato (semantizzazione del significante) nell’ormai unica struttura in cui forme e contenuti si compenetrano irreversibilmente. Si tratta però di una prima e grande classificazione che ha il pregio della semplicità schematica e della efficacia didattica sottolineando, nella struttura della parola-segno, le due componenti fondamentali, l’una fisica, l’altra concettuale, che sono appunto rispettivamente il Significante e il Significato.
Per ovviare comunque all’eccessiva schematizzazione, è necessario sottolineare che molto spesso, nel linguaggio connotativo dei testi poetici, a parità di significante non è tanto il significato a cambiare nel processo figurativo dello slittamento metaforico, bensì il senso di ciò che si vuole dire, che contiene qualcosa che ha a che fare con l’intenzione soggettiva.
Volendo fare degli esempi delucidatori del rapporto significato-senso in cui a parità di significati si hanno diversità di senso, se io dico: “quell’albero è molto fronzuto”, non ci sono dubbi sul significato che è quello di un albero lontano da chi parla molto ricco di rami e foglie.
Non così per il senso poiché quella frase può voler dire, nell’intenzione dell’osservatore, che quell’albero offre uno spettacolo magnifico di verde fogliame, ma può voler dire che toglie la vista panoramica o che intralcia la viabilità o che danneggia con i suoi rami ciò che gli sta vicino.
Pertanto modificheremo quella prima classificazione in :
1) Figure del Significante; 2) Figure del Significato o Semantiche; 3) Figure del Senso o Semasiologiche.
(continua)
di Tino Traina