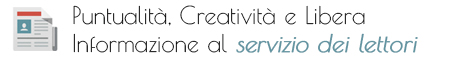In questo argomento faccio riferimento alla potatura dell’ulivo perché fra le culture arboree è stata la più diffusa nelle nostre campagne ad iniziare dai primi del 1800, quando dalla cultura estensiva a grano si passò a quella specializzata più redditizia.
Molti “rimunnatura” (potatori), sia pur pagati con bassi salari, con la “rimunna” (potatura) anche nel passato trovavano occupazione per diversi mesi l’anno. La squadra che eseguiva questo lavoro, era chiamata impropriamente “coppia”; essa era formata da sei “rimunnatura” più un “capuccetta” (capo d’accetta = capo squadra). Il capuccetta era il potatore con più esperienza; anche lui aveva un filare d’ulivi da potare, ma quando sorgeva qualche dubbio fra gli altri potatori, lui doveva lasciare il suo lavoro e decidere, in maniera insindacabile, su come operare. Costui, inoltre, doveva contabilizzare, al proprietario del fondo, il numero degli operai impiegati e le giornate di lavoro eseguite; doveva, inoltre, rendere conto anche della quantità di legna già pronta. A tal proposito, essendo regolarmente analfabeta, adottava un sistema contabile arcaico, ma molto efficiente: teneva nella cintola un rametto d’ulivo su cui faceva un segno col coltello per ogni “cavaddunciu” già pronto.
Un “cavaddunciu” era formato da 10 “mazzi di ligna” (fascine di legna). Ad ogni fine giornata il “capuccetta” contava le tacche segnate, che corrispondevano ai mucchi di legna, e faceva la consegna al proprietario terriero. Per ogni due “coppie di rimunnatura” c’era un “capu d’arti”, che sovrintendeva a tutto il lavoro di potatura; costui in sostanza era il tecnico fiduciario del padrone, spettava a lui decidere il sistema di potatura da adottare per quell’annata agraria: “normali, stritta o china” e rendere conto della qualità di tutto il lavoro. Gli attrezzi di lavoro per la potatura erano la scala a pioli, la sega ad arco, “lu ccittuni” per i tagli più grossi eccezionali, “l’accetta a du manu” per i tagli medi e l’accetta normale per tutti gli altri tagli; a quei tempi non c’erano le forbici e neppure la sega a scoppio; pertanto si faceva molto consumo di “olio di gomito”. In ogni coppia c’era pure una “pecora”: un contadino, chiamato così scherzosamente, perché andava sempre dietro i potatori per completare il lavoro. Egli aveva la funzione di raccogliere e selezionare la legna tagliata dagli alberi durante la potatura, separando i tronchi dal “braccame” (rami) e dal “frascame” (rametti col fogliame), che doveva legare a “mazzi di ligna” (fascine) con le “liame” (strisce di foglie di “zabbara” essiccate al sole).
Le fascine a quei tempi erano importantissime, poiché erano il combustibile più usato e più economico sia per l’artigianato che per gli usi domestici. Il proprietario con il ricavato della vendita di tronchi, rami e fascine recuperava le spese della potatura; oggi, invece, si paga un operaio, per bruciare sul posto tutta la legna. Riguardo all’uliveto vorrei fare una precisazione: gli ulivi erano piantati ad una notevole distanza (anche 11 metri), per essere più arieggiati ed evitare malattie alle piante, ma anche per potere coltivare il terreno con piante erbacee (ortaggi, legumi, frumento) ottenendo due produzioni. Quando un terreno si dava in affitto o a mezzadria, si doveva specificare se si trattava di “sutta” o “supra” o di entrambi, come se si trattasse di due poderi distinti. In mancanza di coltivazioni nella parte di “sutta”, il terreno si dava a pascolo percependo un compenso.
di Vito Marino